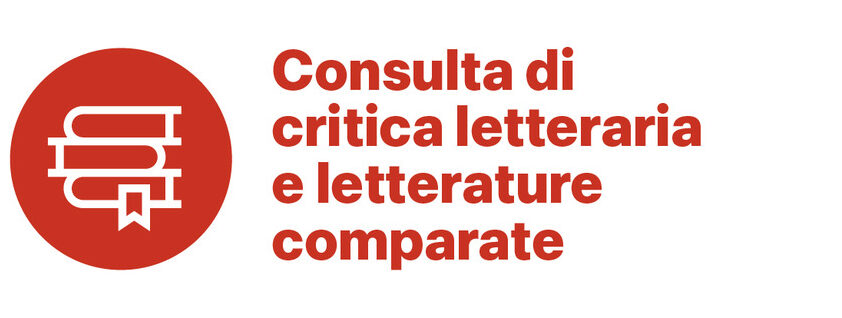Termine invio proposte: 15 maggio 2025
Data di pubblicazione: 30 novembre 2025
https://ojs.unica.it/index.php/between/announcement/view/123
Sin dall’antichità, le narrazioni relative alla fine del mondo hanno dato voce alle ansie e alle crisi delle società che le hanno prodotte. Recenti studi (Pharr, Clark e Firestone 2016; De Cristofaro 2020) dimostrano come l’idea di apocalisse si adatti e cambi a seconda del contesto storico.
Sebbene il “senso della fine” (Kermode 2004) abbia caratterizzato epoche precedenti, dall’inizio del nuovo secolo realtà e immaginazione sono arrivate pian piano a coincidere e il concetto di catastrofe è slittato dall’orizzonte di pensiero del probabile a quello del reale. In questo contesto si assiste a un tentativo da parte delle scienze umane di analizzare i sempre più tangibili mutamenti ambientali antropogenici. Da qualche decennio, prestando attenzione alle diverse categorie sociali ed economiche protagoniste del nostro presente, la riflessione filosofica, la letteratura e le arti, facendosi spazio di elaborazione di quelle ansie che altrove non hanno voce (Orlando 1973), provano a interrogarsi su quali siano le implicazioni antropologiche ed estetiche di un immaginario della fine. Vivendo in un’era di precarietà e di ansia, l’idea di catastrofe, protagonista di un’intensa produzione narrativa post-apocalittica, fantascientifica ed ecodistopica, si incrocia con la riflessione sociale e politica sull’ambiente, diventando «un modo di visualizzare, in maniera diretta e immediatamente percepibile, i pericoli del nostro presente» (Malvestio 2021: 18). Se per diverso tempo il genere post-apocalittico è stato legato esclusivamente alla tradizione angloamericana, a partire dagli anni Duemila in Italia è cresciuto l’interesse per lo studio della relazione tra letteratura ed ecologia, con alcuni fondamentali contributi critici (Scaffai 2017; Benedetti 2021). Particolarmente importanti sono anche le riflessioni sul rapporto tra alcuni generi letterari e la necessità di riflettere sul cambiamento climatico al fine di concepire scenari alternativi (Comberiati 2021).
Dal punto di vista della produzione letteraria, dai primi anni Dieci, si sta assistendo a una proliferazione di opere che collegano scenari apocalittici e cambiamento climatico. Si pensi, in ambito italiano, a romanzi come Sirene (2007) di Pugno, Bambini bonsai (2010) di Zanotti, L’uomo verticale (2010) di Longo, Anna (2015) di Ammaniti (e il suo adattamento nell’omonima serie tv del 2021), Qualcosa là fuori (2016) di Arpaia, La festa nera (2018) di Bellocchio, La galassia dei dementi (2018) di Cavazzoni, L’isola delle madri di Cutrufelli (2020) e Apriti, mare! (2021) di Pariani; senza dimenticare graphic novel come La terra dei figli (2016) di Gipi, Geist Maschine di Ceccotti, Mother (2020) e Troppo facile amarti in vacanza (2021) di Bevilacqua. In ambito internazionale e intermediale si pensi a romanzi e serie tv come The Road (2006) di Cormac McCarthy, Oryx and Crake (2003) di Margareth Atwood, The Walking Dead (2010-2022), The Last of Us (2023-), Station Eleven (2021-), Snowpiercer (2020-2024), Wielka woda (2022) ma anche a graphic novel come Here (2014) di Richard McGuire, Avant l’oubli (2021) di Lisa Blumen, On a Sunbeam (2018) di Tilly Walden, Black River (2015) di Josh Simmons.
Di fronte a un orizzonte degli eventi sempre meno rassicurante, un numero crescente di narrazioni pone una domanda drammatica: cosa accadrebbe se un’improvvisa catastrofe globale spazzasse via la vita umana, animale e vegetale sulla terra (Bellamy 2021). La minaccia climatica ha portato a un’impennata di rappresentazioni di un mondo devastato, in cui i sopravvissuti si trovano alle prese con forme di vita stravolte in un paesaggio distrutto. Le rovine, gli oggetti ormai privi della funzione originaria e il rapporto che i soggetti sopravvissuti instaurano con essi diventa allora un bacino di possibilità per immaginare un’esistenza dopo la catastrofe non priva di potenziali emancipatori e creativi.
Il numero di Between si propone di indagare le riflessioni e la produzione letteraria e intermediale intorno al tema della “catastrofe”. L’obiettivo è da un lato valorizzare i contenuti, le forme e le specificità della narrativa post-apocalittica da una prospettiva comparativa e intermediale, e, dall’altro, di inserirla sia nel contesto delle altre letterature contemporanee che nella lunga tradizione letteraria italiana, entrando così in modo originale nel dibattito critico nazionale e internazionale. Particolarmente graditi saranno quei contributi che discuteranno le implicazioni sociali ed ecologiche delle rappresentazioni apocalittiche, con particolare attenzione all’analisi delle nuove produzioni a partire dal Duemila. Verranno interrogate la ricezione e le politiche editoriali che privilegiano questo tipo di narrazioni. Sono accettati contributi che si occupino dell’argomento sia da un punto di vista teorico che attraverso l’analisi di uno o più casi studio in una prospettiva comparatistica o inter artes. Specificatamente, si incoraggiano proposte legate (ma non limitate) a:
- Generi e motivi della catastrofe (science fiction, distopia, utopia, postapocalittico)
- Immaginari culturali e narrazioni (letteratura, cinema, serialità televisiva, fumetti, arti visive, fotografia)
- Spazi e ambienti del postapocalittico (paesaggi, rovine, oggetti)
- Esperienze di embodiement (rapporti umani, survival, infanzia)
- Gender, prospettiva decoloniale e antispecista (ecofemminismo, queer, animalità, mostruosità)
Il volume è curato da Elisabetta Abignente (elisabetta.abignente@unina.it), Claudia Cao (claudia.cao@unica.it) e Claudia Cerulo (claudia.cerulo@unina.it).
Gli autori sono invitati a consultare la bibliografia riassuntiva alla fine della call for papers. In caso di dubbi e/o per ulteriori informazioni, è possibile inviare una e-mail agli indirizzi delle curatrici.
Gli articoli pronti per la pubblicazione (di lunghezza non superiore a 40.000 caratteri, inclusi spazi, impaginati secondo il Template fornito, con titolo, abstract e metadati in inglese) devono essere inviati alla rivista entro il 1 maggio 2025, seguendo le istruzioni disponibili sulla pagina Proposte del sito web di Between. Gli articoli accettati saranno pubblicati a novembre 2025.
Sono accettati contributi in italiano, inglese e francese o in versione bilingue. Sono particolarmente apprezzate e incoraggiate le proposte in una lingua diversa dall’italiano o in una versione bilingue (di cui una in inglese o francese).
Bibliografia essenziale:
- Barr, Marleen S., Feminist Fabulation: Space/Postmodern Fiction, Iowa City, University of Iowa Press, 1992.
- Bellamy, Brent Ryan, Remainders of the American Century. Post-Apocalyptic Novels in the Age of US Decline, Middletown CT, Wesleyan University Press, 2021.
- Benedetti, Carla, La letteratura ci salverà dall’estinzione, Torino, Einaudi, 2021.
- Bladow, Kyle; Ladino, Jennifer, Affective Ecocriticism. Emotion, Embodiment, Environment, Lincoln, University of Nebraska Press, 2018.
- Brioni, Simone; Comberiati, Daniele, Ideologia e rappresentazione. Percorsi attraverso la fantascienza italiana, Milano-Udine, Mimesis, 2020.
- Brioni, Simone; Comberiati, Daniele, Italian Science Fiction. The Other in Literature and Film, London, Palgrave Macmillan, 2019.
- Comberiati, Daniele, Il mondo che verrà. Cinque ipotesi di ricostruzione dell’umanità nelle narrazioni distopiche, Milano, Mimesis, 2021.
- Comberiati, Daniele; Somigli, Luca, «La fantascienza nelle narrazioni italiane ipercontemporanee», Narrativa, 43, 2021, pp. 1-11.
- Curti Lidia (a cura di), Femminismi futuri, Roma, Iacobelli, 2021.
- De Cristofaro, Diletta, The Contemporary Post-Apocalyptic Novel, London, Bloomsbury, 2020.
- De Martino, Ernesto, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Torino, Einaudi, 1977.
- Fragnito, Maddalena; Tola, Miriam, Ecologie della cura. Prospettive transfemministe, Napoli, Orthotes, 2021.
- Gallo, Domenico, «Fantascienza Outside the Ghetto: The Science-Fictional Writings of Italian Mainstream Authors», Science Fiction Studies, vol. 42, n. 2, 2015, pp. 251-273.
- Giuliani, Gaia, Zombie, alieni e mutanti. Le paure dall’11 settembre a oggi, Milano, Mondadori, 2015.
- Hicks, Heather, The Post-apocalyptic Novel in the Twenty-First Century, New York, Palgrave McMillan, 2016.
- Iannuzzi, Giulia, Distopie, viaggi spaziali, allucinazioni. Fantascienza italiana contemporanea, Milano, Mimesis, 2015.
- Iovino, Serenella, Ecocriticism and Italy: Ecology, Resistance, Liberation, London, Bloomsbury Academic, 2016.
- Lino, Mirko, L’apocalisse postmoderna tra letteratura e cinema. Catastrofi, oggetti, metropoli, corpi, Firenze, Le Lettere, 2014.
- Malvestio, Marco, Raccontare la fine del mondo. Fantascienza e Antropocene, Milano, Nottetempo, 2021.
- McNeil, John; Engelke, Peter, La Grande accelerazione. Una storia ambientale dell’Antropocene dopo il 1945, Torino, Einaudi, 2018.
- Micali, Simona, Towards a Posthuman Imagination in Literature and Media, Berlin, Peter Lang, 2019.
- Morton, Timothy, Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World, Minneapolis, University of Minneapolis Press, 2013.
- Mussgnug, Florian, «Finire il mondo. Per un’analisi del romanzo apocalittico italiano degli anni Settanta», Contemporanea, n. 1, 2003, pp. 19-32.
- Muzzioli, Francesco, Scritture della catastrofe. Istruzioni e ragguagli per un viaggio nelle distopie, Milano, Meltemi, 2021.
- Orlando, Francesco, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura, Torino, Einaudi, 2015.
- Orlando, Francesco, Per una teoria freudiana della letteratura, Torino, Einaudi, 1973.
- Proietti, Salvatore, «The Field of Italian Science Fiction», Science Fiction Studies, vol. 42, n. 2, 2015, pp. 217-231.
- Scaffai, Niccolò, Letteratura e ecologia. Forme e temi di una relazione narrativa, Roma, Carocci, 2017.
- Stock, Adam, Modern Dystopian Fiction and Political Thought. Narratives of World Politics, New York, Routledge, 2018.
- Vakoch, Douglas; Mickey, Sam, Literature and Ecofeminism, Oxon, Routledge, 2018.
- Watkins, Susan, Contemporary Women’s Post-Apocalyptic Fiction, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2020.